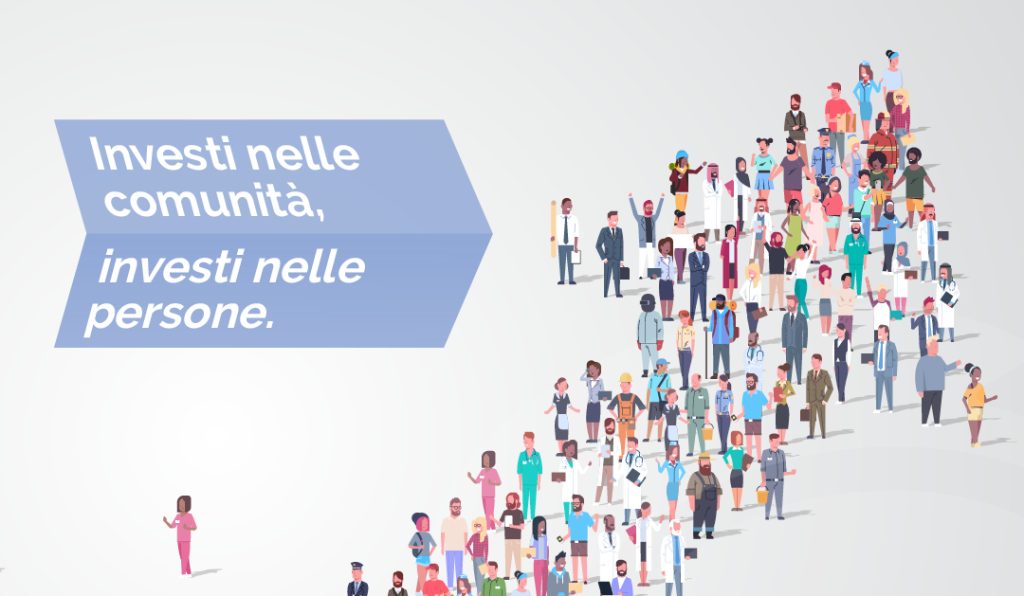Un Paese che invecchia in un continente che invecchia: è nota la fotografia che già da qualche anno immortala l’andamento demografico italiano, con una popolazione Over 65 di oltre 14,5 milioni di persone, quasi il 25% del totale.
Un doppio movimento di invecchiamento “dall’alto” (aumenta la longevità) e “dal basso” (diminuiscono le nascite) che cambia radicalmente il sistema della cura e dell’assistenza a chi progressivamente è destinato a vedere scemata la propria autosufficienza, sistema che oggi in Italia si regge in larghissima parte sul lavoro invisibile dei caregiver formali e informali. Sono oltre 8,5 milioni le persone che, spesso senza formazione e con pochi strumenti, colmano il divario tra una domanda crescente di assistenza e un’offerta pubblica e privata insufficiente. Caregiver formali e informali, familiari ma anche amici o vicini di casa, nella stragrande maggioranza – 70% del totale – donne che offrono supporto sanitario e logistico, dalla cura della persona a quella della casa, dalla mobilità all’alimentazione, ma anche emotivo e sociale, e che rappresentano una componente irrinunciabile del sistema socio-sanitario nazionale: oggi una donna di 30 anni ha in prospettiva davanti a sé circa 18 anni in cui svolgerà funzioni di assistenza a familiari.
Si focalizzano sull’universo dei caregiver, formali e informali, le ricerche condotte dai team di Università di Bologna e Università del Molise assieme a partner istituzionali e privati (UNIMIB, UNIPD, INRCA, BETA 80, ISTAT) presentate ieri nell’ambito di un convegno a Bologna: le ricerche rientrano nell’ambito dello Spoke 5 “Sostenibilità dei sistemi di cura all’anziano in una società che invecchia” del progetto Age-It, il programma di investimento PNRR finalizzato a rafforzare la rete dei centri di ricerca italiani che operano nel settore dell’invecchiamento.
Un lavoro che segna un deciso cambio di prospettiva, focalizzandosi non solo sui care-receiver e sugli interventi di tipo sanitario, ma sui caregiver. “Il benessere sociale, psicologico e fisico dei caregivers diventa centrale nel nostro approccio, e si traduce, nelle soluzioni prospettate, in un miglioramento dell’intero sistema di cura – dice Marco Albertini, Professore ordinario del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali di Unibo e responsabile del progetto.
“Dobbiamo partire da un assunto di base: anche se oggi avessimo a disposizione budget illimitati per la cura agli anziani ci mancherebbero comunque le persone – continua il Prof. Albertini. – Per questo la sostenibilità del sistema, oggi gravata dal sempre più ampio divario tra una domanda crescente di assistenza e un’offerta pubblica e privata insufficiente, deve essere costruita ripensando profondamente come la società produce, distribuisce e riceve cura”. Spoke 5 lavora su una prospettiva integrata che tiene insieme dimensioni sociali, psicologiche, educative, tecnologiche e di policy, concentrandosi non solo su chi riceve cura, ma anche – e soprattutto – su chi dà cura, prevenendo, ad esempio, il logoramento psicologico, fisico e sociale che colpisce chi si fa carico della cura quotidiana: la ricerca parte dalla consapevolezza che rafforzare il benessere e le competenze dei caregiver significa rendere sostenibile l’intero sistema.
Mappare, monitorare, formare, ridisegnare, riconoscere, trasformare: sono i verbi che raccontano le direttrici sulle quali si è mossa la ricerca, che ha impegnato più di 50 ricercatrici e ricercatori per 3 anni di progetto, coinvolgendo anche poco un centinaio di stakeholder, organizzazioni e istituzioni di tutto il territorio italiano. Tra piattaforme per la formazione, mappature dei territori comunali per individuare possibili miglioramenti nella distribuzione dei servizi e sviluppo di chatbot dedicati a fornire supporto e assistenza per le problematiche quotidiane, fino alla raccolta delle storie dei caregiver per dare visibilità e riconoscimento sociale a figure spesso “sommerse”, sono diversi gli ambiti di sviluppo della ricerca. “Spoke 5 non mira a creare servizi isolati o progetti pilota, ma a costruire una visione sistemica e sostenibile della cura, un sistema che parte dai dati e arriva alle persone, che unisce tecnologia e relazioni, ricerca e comunità” dice il prof. Albertini.
Mappare i rischi: dove la cura è più fragile
Il primo passo è stato quello di “mappare” il territorio per individuare i territori più fragili nel rapporto tra domanda potenziale e offerta di cura, sviluppando l’Indicatore Comunale di Criticità Potenziale (ICCP), costruito attraverso l’analisi combinata di dati demografici, socio-economici e sanitari a livello comunale. “Il risultato – spiega la Professoressa Tomassini (Unievrsità del Molise) – è una mappa dell’Italia che sorprende: la fragilità non segue più la linea Nord-Sud, ma si distribuisce in modo irregolare, attraversando aree urbane, montane e interne”. Sorprende ad esempio il 10,3% di territori fragili in Emilia-Romagna, Regione all’avanguardia per welfare e assistenza socio-sanitaria, contro all’8,7% della Calabria, normalmente fanalino di coda. “L’ICCP può diventare uno strumento operativo per Comuni e decisori pubblici, utile per orientare risorse e disegnare politiche di prevenzione e supporto più mirate” conclude il Prof. Albertini,
Monitorare e prevenire: la cura come auto-cura
Il secondo asse del progetto riguarda il monitoraggio del benessere dei caregiver: non solo fisico o psicologico, ma anche sociale. Attraverso gli studi ICare.IT – AvereCura e CARE, che coinvolgono caregiver di anziani con demenza e Alzheimer, o anziani dimessi dopo scompensi cardiaci, vengono sperimentati sensori indossabili (come holter cardiaci e orologi per il monitoraggio del sonno), web app e applicazioni capaci di segnalare situazioni di rischio per la salute di chi riceve cura e del caregiver stesso. “L’obiettivo non è solo raccogliere dati, ma stimolare l’auto-monitoraggio – dicono i Professori Domenicali (Università di Bologna) e Testa (Università del Molise). – Aiutare chi dà cura a riconoscere quando sta mettendo a rischio il proprio benessere, per evitare il collasso emotivo e fisico che spesso accompagna la cura prolungata”.
Formare e connettere: il progetto Care.In.For.
A supporto delle competenze e della rete di supporto dei caregiver, Spoke 5 sotto il coordinamento del prof. Rabih Chattat (Università di Bologna) e attraverso la collaborazione con Anziani e non solo – Società Cooperativa Sociale, Melazeta s.r.l. e Consorzio SOL.CO. Nuoro – società cooperativa sociale, ha sviluppato Care.In.For., una piattaforma di formazione pensata per chi si prende cura di un familiare o amico anziano: brevi contenuti video, validati e co-progettati insieme ai caregiver e alle loro associazioni, che affrontano in modo pratico i temi più ricorrenti, dalla gestione dello stress alla comunicazione con la persona assistita, dall’organizzazione del tempo alle tecniche di cura e assistenza di base. La piattaforma è anche un luogo d’incontro: permette lo scambio tra pari in uno spazio digitale sicuro, con contenuti controllati per evitare la disinformazione. Il sistema di badge e riconoscimenti favorisce la motivazione e il senso di comunità, ponendo le basi per una piattaforma inclusiva.
Un chatbot per la cura quotidiana
Quando la stanchezza e l’incertezza prendono il sopravvento, la tempestività di una risposta può fare la differenza: Spoke 5 in collaborazione con Youbiquo e Tamlab, sta sviluppando un chatbot dedicato ai caregiver di anziani con demenza e Alzheimer, alimentato esclusivamente da fonti validate e aggiornate. Il suo scopo è fornire supporto pratico, immediato: suggerimenti sui comportamenti da adottare, indicazioni per gestire situazioni critiche e riferimenti a servizi e organizzazioni territoriali che possono aiutare chi dà cura. Un esempio concreto di come l’uso attento e controllato dell’intelligenza artificiale possa sostenere chi dà cura, senza sostituirsi al supporto umano e professionale.
Ridisegnare l’ambiente: la cura passa anche dallo spazio
Cambiare il contesto in cui le persone vivono può fare la differenza, soprattutto nel caso della non autosufficienza: rimuovere gli ostacoli nello spazio quotidiano di movimento può fare la differenza. Per questo Spoke 5, con il team guidato dalla Professoressa Bandini (Unversità di Milano Bicocca) ha sperimentato, in alcuni comuni di dimensioni ridotte delle aree interne, un modello integrato di progettazione territoriale basato su rilievi con droni, simulazioni comportamentali e dati raccolti da sensori ambientali: ridistribuzione dei servizi, miglioramento della viabilità pedonale, parcheggi funzionali a raggiungere, ad esempio, uno studio medico o una farmacia possono ritardare la perdita di autonomia e, di conseguenza, ridurre la domanda di cura. Il risultato è un pacchetto operativo di strumenti per i Comuni, utile per pianificare in modo scientifico e accessibile le politiche urbanistiche e sociali.
Dare visibilità sociale alla cura
Spoke 5 promuove anche un cambiamento culturale. Il caregiving in Italia resta un fenomeno invisibile, per lo più femminile, raramente riconosciuto come dimensione pubblica del welfare e nel discorso politico: attraverso la creazione di un archivio online di biografie di caregiver, il progetto Caregiver – Storie di Vita e di Cura intende dare volto e voce a chi si prende cura di familiari e amici, stimolando la ricerca, il dibattito pubblico e la consapevolezza collettiva. Raccontare queste storie significa trasformare la cura in un fatto sociale, non solo privato: un gesto di responsabilità che riguarda l’intera comunità.
Dalla conoscenza all’azione: politiche di supporto
Una volta mappati i rischi, formate le persone, monitorati i bisogni e ridisegnato l’ambiente, serve un sistema di politiche e interventi capace di mettere a valore queste evidenze e strumenti. Il progetto, con il gruppo coordinato dal Dott. Lamura (INRCA) analizza e confronta le politiche di supporto ai caregiver ai diversi livelli istituzionali (locale, regionale, nazionale), identificando modelli di governance, politiche e interventi di supporto alla cura informale che hanno dimostrato la loro efficacia nei contesti in cui sono state implementate. L’obiettivo è trasformare la conoscenza in decisione pubblica, costruendo politiche basate su evidenze, comparazioni e coordinamento multilivello.